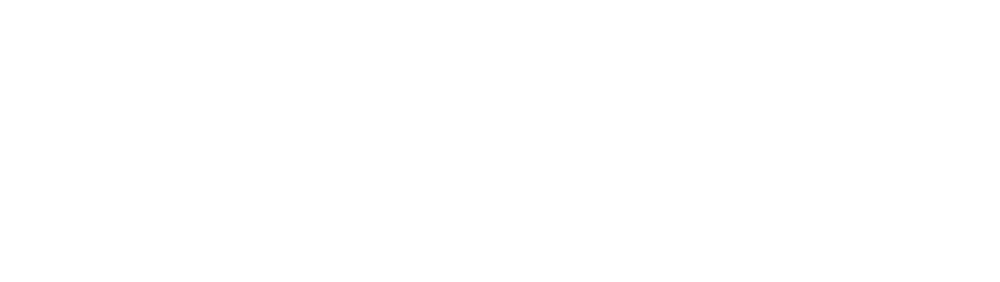Le emigrazioni tra l'Unità e la grande guerra
Bibliografia
Apri il menù
La “grande emigrazione” italiana (1876-1914) è il fenomeno migratorio più studiato, ma negli anni recenti si è posto maggiore attenzione sulla “nuova emigrazione”. Gli storici hanno esaminato le dinamiche migratorie postunitarie, focalizzandosi sulla mobilità interna e le politiche migratorie. Tuttavia, non si è approfondito abbastanza come queste politiche fossero influenzate dagli spostamenti interni, e non si è svolta un’analisi comparata tra l’emigrazione italiana e le politiche degli altri Stati. La Prima guerra mondiale ha segnato un cambiamento, ma le partenze non si sono interrotte. Durante gli anni Venti, le politiche anti-immigratorie americane hanno ostacolato l’emigrazione verso gli Stati Uniti, favorendo invece la creazione di “Piccole Italie” in Europa. Il regime fascista ha modificato ulteriormente i flussi migratori, promuovendo la mobilità interna verso colonie, aree di bonifica e città nuove. L’emigrazione ha radici storiche profonde, ma solo dopo il 1870 sono emerse statistiche ufficiali sul fenomeno. Prima di tale data, l’emigrazione era già un problema, con flussi provenienti dalle regioni povere dell’Italia. Negli anni Settanta, l’economista Leone Carpi ha denunciato la crescente emigrazione, legata alle politiche economiche liberiste e allo sfruttamento delle campagne. Il dibattito sull’emigrazione ha diviso le élite italiane, con interventi anche da parte della Chiesa, soprattutto dai vescovi settentrionali, che hanno cercato di proteggere i migranti. Tra questi, Giovanni Battista Scalabrini ha promosso un’azione nazionale di supporto, ma si è scontrato con l’opposizione della Santa Sede e dei cattolici più intransigenti. Anche a causa delle difficoltà politiche e sociali in Italia, le partenze sono aumentate, alimentate dalla povertà rurale, dai conflitti sociali e dalla coscrizione militare obbligatoria.